

Cinema
Il Signore delle Nevi, il documentario di Correale
Storia delle neviere in Sicilia
di Nello Correale
Venerdi, 11 novembre ore 16.00 Sala Bianca
Centro Sperimentale di Cinematografia – Palermo
Sarà il Direttore dell’Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo della Regione siciliana, Alessandro Rais, a introdurre la presentazione del film: “Il Signore delle Nevi, Storia delle neviere in Sicilia” di Nello Correale. L’incontro sarà una sorta di lezione aperta agli studenti del Centro Sperimentale di Cinematografia e a quanti vorranno conoscere la genesi e l’evoluzione di questo importante lavoro filmico. A incontrare gli studenti e il pubblico, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti, l’autore e il regista Nello Correale, assieme a Vittoria Alliata, diretta discendente del Principe di Villafranca, Francesco e lo storico del cinema Sebastiano Gesù. Modera il direttore della sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia, il giornalista Ivan Scinardo.
“Il film – sottolinea Correale – racconta una Sicilia inedita. La terra del sole, del mare, del sale e del grano, che ha prodotto il ghiaccio per tutto il Mediterraneo e ne ha mantenuto il monopolio del commercio per circa due secoli; è un omaggio a Francesco Alliata, principe di Villafranca, “l’ultimo signore delle nevi” e di molti altri luoghi di quella Sicilia alla quale ha dedicato l’impegno di una lunga e avventurosa esistenza, magistralmente narrata nelle sue memorie: Il Mediterraneo era il mio regno. Il film è un viaggio quasi sentimentale nel “cuore freddo” dell’isola”.
Il Signore delle Nevi è prodotto da Tipota Movie Company, in collaborazione con Panaria Film. “Realizzato nell’ambito del Programma Sensi Contemporanei Cinema”, con il contributo della Regione Siciliana, assessorato Turismo Sport e Spettacolo-Ufficio speciale per il Cinema e l’Audiovisivo, di Sensi Contemporanei, della Sicilia Film Commission, della Direzione generale per il cinema del Mibact, dell’Agenzia per la Coesione Territoriale.
Secondo il regista, «l’obiettivo del film è dare una nuova e più sistematica interpretazione antropologica alle fonti utilizzate per la ricostruzione dell’attività dei nevaioli siciliani. La narrazione avviene attraverso un racconto di immagini, suoni e parole dell’avvincente storia della neve e della sua lavorazione». Correale ricorda che la neve, per secoli, «è stata un bene prezioso non solo in campo alimentare, ma soprattutto in quello medico, per l’azione benefica che la “cura del freddo” aveva specialmente nei casi di emorragia e febbre alta. L’uomo cercò di godere di questo privilegio anche durante i mesi torridi, utilizzando ciò che la natura metteva a disposizione. Nella raccolta e nella conservazione della neve furono coinvolte numerose persone, alimentando una fiorente attività commerciale che, negli anni Cinquanta, lasciò il passo allo sviluppo tecnologico. Oggi sembra quasi una favola. Sono rimasti solo i luoghi dove veniva ammassata la neve. Eppure un tempo, durante le notti d’estate, lunghe file di muli scendevano dalle alte falde della “Montagna” con due grossi blocchi di neve con sulla groppa. Grazie all’uso dei carretti i blocchi venivano trasportati giù per il refrigerio della popolazione».


La storia
—————–
La registrazione della conferenza avvenuta venerdi 11 novembre al Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo. Interventi di: Alessandro Rais, Vittoria Alliata, Nello Correrale. Modera Ivan Scinardo:
IL SIGNORE DELLA NEVE.
La storia delle neviere in Sicilia
di Nello Correale (c) siae
Sino al secolo scorso si commerciava la neve da Trapani a Tunisi su navi a vela e le neviere che rifornivano Palermo erano sui monti dietro Monreale ed una, della “Busambra”, presso Corleone. Dall’altipiano degli Iblei e dall’Etna, invece, la neve veniva inviata alle città sulla costa ionica e mediterranea, fino a raggiungere l’isola di Malta.
La Sicilia, la terra del sole, del mare , del sale e del grano ha prodotto il ghiaccio per tutto il Mediterraneo e ne ha mantenuto il monopolio del commercio per circa due secoli.
Attraversando i luoghi interessati ricostruiremo un percorso guidati dal principe Francesco Alliata di Villafranca ” l’ultimo signore della neve” ,oggi ultranovantenne, che dalle pendici del vulcano che domina il Mediterraneo ci condurrà a Buccheri, a Monterosso ,a Palermo, ai Nebrodi e racconteremo di coloro che hanno fatto della “coltivazione” della neve una attività che è resistita per secoli innestandosi nella cultura popolare siciliana.
Obiettivo di questo Film/documentario è dare una nuova e più sistematica interpretazione antropologica alle fonti utilizzate per la ricostruzione dell’attività dei nevaioli siciliani. Raccontare attraverso un racconto di immagini, suoni e parole la storia avvincente della neve e la sua lavorazione. L’uso del ghiaccio e le moderne strutture in cui oggi viene prodotto in uno scenario particolare come quello del Mediterraneo e soprattutto in Sicilia. Il film documentario sarà realizzato con il sostegno della Regione Sicilia, in formato full HD e avrà la durata di 52’ ed è stato già richiesto da molte televisioni sia italiane che straniere.
L’importanza attribuita nel passato alla neve e alle neviere è testimoniata, ancora oggi, dalla presenza nei centri abitati di numerose chiesette consacrate alla Madonna della Neve. Infatti era molto diffusa l’usanza, e non solo nel meridione, d’invocare la protezione divina sulle neviere.
Si guarda a quest’attività in una scala più ampia, quella del Mediterraneo, descrivendo la raccolta, la produzione e la conseguente costituzione delle Società per la vendita della neve, prendiamo in considerazione sia le diverse tipologie costruttive con cui sono state edificate le neviere siciliane che i materiali da costruzione impiegati e i diversi tipi di consumo del prodotto ricavato dalla lavorazione della neve. Una panoramica sulle forme di trasporto e di commercializzazione della neve, compiuti da abili mulattieri e carrettieri dopo, lungo le trazzere che portavano alla marina dove sorgeranno le prime botteghe del ghiaccio.
“La neve per secoli è stata un bene prezioso non solo in campo alimentare, ma soprattutto in quello medico per l’azione benefica che la “cura del freddo” aveva specialmente nei casi di emorragia e febbre alta. L’uomo dunque cercò di potere godere di questo privilegio, anche durante i mesi torridi, utilizzando ciò che la natura gli metteva a disposizione. Per secoli, dunque, la raccolta e la conservazione della neve coinvolsero un gran numero di persone alimentando una fiorente attività commerciale, che negli anni ’50 del ‘900 lasciò il passo allo sviluppo tecnologico. Oggi sembra quasi una favola, nessuno si occupa di questo commercio; sono rimasti solo i luoghi dove veniva ammassata la neve. Eppure un tempo, durante i mesi estivi di notte, lunghe file di muli scendevano dalle alte falde della “Montagna”, provenienti proprio dalle zone della tacche, con sulla groppa due grossi blocchi di neve che poi per mezzo di carretti venivano trasportati giù per il refrigerio della popolazioni. La “campagna” di raccolta della neve offriva non poco lavoro agli abitanti delle pendici dell’Etna. L’impiego di uomini, animali e mezzi era alquanto consistente: un migliaio circa di persone avevano la possibilità di lavorare e altrettanti animali venivano utilizzati per il trasporto.
Oggi inghiottite dal paesaggio montano, le neviere, esaurita la loro funzione, sembrano rientrate nel grembo della terra per testimoniare con voce sommessa un’antica arte e un’attiva industria, ma soprattutto un uso intelligente ed accorto delle risorse naturali.
Chiare testimonianze di archeologia industriale, spesso celate agli occhi dal rialzamento dei terreni, o sottoposte a mutamenti funzionali, queste strutture hanno portato alla realizzazione sul territorio di spazi che hanno connotato un modus vivendi, e definito mode e modi di vita. “
Coltivare la neve , questo era l’attività dei nevaioli che cercheremo di far vivere attraverso ricostruzioni storiche e fotografiche. Una attività molto diffusa fino all’avvento della produzione industriale del” freddo”
Due erano i metodi di raccolta della neve: o veniva raccolta in mucchi e caricata su delle barelle, oppure sì faceva una palla (bbadda) attorno ad un bastone che fungeva da perno, la si caricava sulle spalle fino alla bocca della neviera attraverso cui si precipitava dentro.
Quest’ultimo è il sistema più antico, poiché da sempre la paga era commisurata al numero di palle portato alla neviera da ciascun operaio. Quattro uomini, calatisi all’interno della neviera e chiamati pisaturi (battitori, calpestatori) avevano il compito di calpestare in continuazione la neve, pressandola e ricoprendo lo strato con paglia. La neve veniva in questo modo assularata. Ogni sulata, cioè ogni strato, misurava in spessore (quando era compatto) da 20 a 30 cm e determinava la grandezza della neviera: così la ‘Grotta Grande”, la più grande neviera del comune, conteneva 365 strati, uno per ogni giorno dell’anno (come ripetevano gli stessi operai)
Ma ai fini della vendita si misurava a carichi venduti “a bocca di nivera“, cioè appena uscita dalla porta e pesata sul posto. Ogni carico equivaleva a due palle e, poiché ogni palla pesava intorno da 50 a 60 kg, un carico oscillava da 100 a 120 kg.
La neve era compressa da esperti pestatori, pisaturi, che calzavano le scarpe di pelo (zampitti), le cui stringhe attorcigliavano alle caviglie, che a loro volta erano fasciate con pelli di capra. Appena la neve compressa raggiungeva su tutta la superficie lo spessore desiderato (da 20 a 30 cm) si spargeva su tale superficie uno strato (na sulata) di paglia, che separava questo dal suolo successivo, così da favorire il distacco nel periodo della tagliatura. Altra paglia separava la neve dalle pareti laterali. Ogni suolo era formato da un certo numero di carichi: il numero variava in base alla larghezza della neviera. Quando la neviera era al colmo, cessava il lavoro dei “pisaturi“, che provvedevano a collocare gli ultimi strati di paglia sulla superficie e sui lati della fossa. Il loro controllo continuava nel periodo estivo, quando dovevano verificare il “calo” della neve e il grado di distacco dalle pareti.
Per il taglio della neve venivano impiegati operai specializzati. Questi, scesi nella neviera, incidevano il ghiaccio col piccone fino a raggiungere lo strato di paglia; poi con una paletta staccavano il blocco che ne veniva fuori. Il blocco veniva infilato in un sacco di lona, riempito di paglia e tirato fuori per essere pesato: l’abilità del tagliatore stava nel tagliare i blocchi del peso di 60 kg, peso di una palla, poiché due di queste formavano un carico.
Anticamente le neve si trasportava a basto di mulo, portando ogni mulo un carico, cioè due blocchi. Successivamente con l’introduzione dei carretti si ricorse a questi mezzi di trasporto .
Ogni carro portava cinque carichi. Un carro di 5 carichi veniva pagato a Lentini 100 lire nel 1940, di cui 50 per il trasporto e 50 per il prezzo della neve. Come detto ogni neviera aveva un suo preciso territorio da cui raccogliere neve. Questo se i terreni erano privati.
Tra il 1500 e il 1900, dalle Madonie ai Nebrodi, dai monti Peloritani all’Etna per passare infine all’Altopiano degli Iblei crebbe una realtà legata al lavoro della raccolta della neve, che ha dato forma a una serie di costumi e usanze.
Per quanto conosciute e scarsamente valorizzate, le neviere siciliane rappresentano una traccia indelebile del territorio regionale. Abbandonate, alcune semi-distrutte, altre riadattate per diversi scopi, i nevai ancora esistenti nell’area iblea presentano una forma semplice e la loro struttura cristallina ne fa uno dei capolavori dell’architettura minore siciliana.
Ciò dimostra l’importanza che ha avuto il fenomeno dell’espansione dell’industria legata al commercio della neve. Le popolazioni che ebbero a che fare con il suo utilizzo acquisirono una maggiore consapevolezza della possibilità di investire parte del loro capitale umano e finanziario per la crescita dell’attività di raccolta.
Cinema
Sergio Castellitto e Marco Bellocchio

Attori e registi, a capo di CSC e Cineteca di Bologna parlano di sogni e bisogni della cultura del grande schermo. Ma anche dei set che hanno vissuto insieme
“Il Centro Sperimentale di Cinematografia è un posto seducente e ammaliante: solo passeggiare per i suoi corridoi, gli stessi che hanno vissuto la presenza per diversi anni di Roberto Rossellini, significa provare una emozione del tutto particolare” ha detto il Presidente Sergio Castellitto, il 28 giugno, a Bologna, al cinema Modernissimo. “Ho un rapporto del tutto speciale con il Centro Sperimentale – ha detto Marco Bellocchio che era seduto insieme a lui e a Gianluca Farinelli di fronte ad una platea gremita – per qualche anno vi ho anche insegnato. All’epoca iniziai come attore ma fu Camilleri, che era insegnante, a consigliarmi di fare successivamente il corso come regista”. Entrambi, presenti al Cinema Ritrovato, sono stati invitati allo stesso desk dal presidente Farinelli per assistere ad un dialogo che li vede entrambi manager (certo “atipici” come li ha definiti alla fine dell’incontro) di due istituzioni cardinali del cinema pubblico: il Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale e la Cineteca di Bologna (di cui Bellocchio è presidente).
 “E’ molto importante quello che ha fatto Sergio – ha detto Bellocchio – aprendo il Centro per la prima volta a tutti con i giorni della Diaspora degli Artisti in Guerra: se vorrà, in futuro, in questa direzione, sarei lieto di poter collaborare in qualche modo”. “La scelta della Diaspora – ha detto
“E’ molto importante quello che ha fatto Sergio – ha detto Bellocchio – aprendo il Centro per la prima volta a tutti con i giorni della Diaspora degli Artisti in Guerra: se vorrà, in futuro, in questa direzione, sarei lieto di poter collaborare in qualche modo”. “La scelta della Diaspora – ha detto
Castellitto – nasce dall’idea di mettere la “carne del dolore del mondo” al centro di un evento con il quale aprire per la prima volta le porte della Scuola e della Cineteca al mondo esterno e non solo ai 260 allievi che la frequentano ogni giorno e tra i quali ci sono i talenti del cinema italiano di doman. Risultato: abbiamo avuto più di 700 persone al giorno, per la metà sotto i 30 anni”.
Farinelli ha sottolineato anche le analogie artistiche e gli incroci biografici: entrambi hanno iniziato come attori e sono diventati registi (“Ma io sono diventato regista per trasferire sullo schermo la narrazione e le immagini che mi avevano suscitato i libri di Margaret Mazzantini”, ha detto il Presidente del Centro Sperimentale), hanno fatto due film insieme, L’ora di religione e Il regista di matrimoni (“In realtà due e mezzo – ha aggiunto Castellitto – perché ho doppiato Lou Castel in Gli occhi, la bocca: anche se Lou, poco prima che iniziassi, mi ha pregato in ginocchio di rifiutare perché non voleva essere doppiato”) ed ora entrambi, senza essere manager, si ritrovano a capo di due istituzioni cruciali per la preservazione, la conservazione e il restauro del patrimonio cinematografico. “Ma io non faccio quasi niente – ha detto Bellocchio – Bologna dispone di una macchina organizzativa incredibile”. “Io non sono nato manager e non morirò tale, ma sto scoprendo quanto è difficile esserlo continuando ad occuparsi fondamentalmente di cultura”.
E’ sul set, come è stato il loro incontro? Il ricordo più suggestivo è di Bellocchio ma riguarda da vicino Sergio. “La famosa bestemmia di L’ora di religione: una bestemmia
ripetuta due volte. Cosa ci può essere dopo qualcosa del genere? Sergio ha avuto questo gesto spontaneo, fraterno, toccante di abbracciare il fratello dopo quella imprecazione così disperata. Non c’era in sceneggiatura e non gli ho suggerito io di farlo. Ma ha dato a quella scena un accento ed una intensità uniche e gli sono grato per questo”. (Fonte: https://www.fondazionecsc.it/castellitto-e-bellocchio-due-manager-atipici-per-la-conservazione-la-formazione-e-il-futuro-del-cinema/)
Cinema
Un film lungo 70 anni. Al via il festival di Taormina

Taormina, 28 giugno 2024 – Dall’avventura action al thriller psicologico, dall’horror alla romantic-comedy e alle molteplici facce di un cinema siciliano che avanza a 360 gradi: sono questi soltanto alcuni dei fili che il Direttore del Taormina Film Festival, Marco Müller, ha scelto di intrecciare nel concepire un programma che sia capace di soddisfare tutti i tipi di pubblico, dagli appassionati di blockbuster pop al cinema italiano, sotto le stelle del Teatro Antico.
Un Festival che si inaugura venerdì 12 luglio con un evento speciale dei Nastri d’Argento per celebrare il 70° anniversario con un omaggio alla commedia italiana: grandi protagonisti Christian De Sica, Carlo Verdone e molti altri. Tante le presenze internazionali, tra cui Sharon Stone, Nicolas Cage, Bella Thorne, Rebecca De Mornay, solo per citare alcuni nomi.
Il cuore del Taormina Film Festival è il Gala che ospiterà 7 titoli tutte le sere al Teatro Antico, fra cui ben 4 prime mondiali e un’attenzione particolare al giovane cinema con opere prime e seconde. Si parte il 13 luglio con l’horror statunitense Saint Clare di Mitzi Peirone con Bella Thorne, Rebecca De Mornay e Ryan Philippe, per proseguire con il travolgente action movie Twisters di Lee Isaac Chung interpretato da Daisy Jessica Edgar-Jones.
Tanto Cinema e spettacolo
E poi il thriller-psicologico The Surfer di Lorcan Finnegan con Nicolas Cage; Il giudice e il boss,che il regista di Placido Rizzotto, Pasquale Scimeca, dedica alla memoria di un eroe dell’antimafia come Cesare Terranova; e un trittico di rom-com con il britannico-islandese Touch, diretto dal celebre regista Baltasar Kormákur e interpretato dalla gettonatissima modella e cantante giapponese Kôki, e le due italiane L’invenzione di noi due di Corrado Ceron con Lino Guanciale, Silvia D’Amico e Paolo Rossi e Finché notte non ci separi di Riccardo Antonaroli interpretato da Pilar Fogliati, Filippo Scicchitano, Valeria Bilello, che chiude la rassegna.
Centrale nella programmazione del Palazzo dei Congressi è il FOCUS MEDITERRANEO, che permette al festival di aprirsi al mondo e inserirsi nelle sue contraddizioni più scottanti, a partire dalla prima internazionale di From Ground Zero, il film collettivo coordinato da Rashid Masharawi che presenta il “racconto di storie non raccontate” firmate da 22 giovani cineasti palestinesi che hanno filmato la vita quotidiana a Gaza.
Il maestro del cinema israeliano Amos Gitai torna a Taormina con Shikun, compendio del suo cinema e della sua visione delle contraddizioni del paese, mentre in To A Land Unknown, Mahdi Fleifel scava nel mondo degli immigrati arabi clandestini nei paesi della UE. Due grandi presenze autoriali francesi vengono ospitate dal Focus Mediterraneo: la prima internazionale della versione integrale di Va savoir di Jacques Rivette, il film pirandelliano interpretato da Sergio Castellitto, che introdurrà la proiezione e la prima mondiale di Filmlovers! di Arnaud Desplechin, versione in lingua inglese di Spectateurs, il film in cui il regista francese ha celebrato la magia del cinema visto in sala. Fresco dei suoi successi hollywoodiani, il regista cileno-svedese Daniel Espinosa ambienta nel Meridione italiano la storia di una trafficante di uomini nel suo nuovissimo Madame Luna, mentre Thierry de Peretti con il suo A son image torna nella sua Corsica natale per raccontare attraverso la vita, le amicizie e gli amori di una giovane fotografa i tumulti politici dell’isola dalla fine degli anni ’70 in poi.
 Sempre al Palazzo dei Congressi uno spazio speciale è dedicato a OFFICINA SICILIA, in cui coesistono anime diverse fra loro. Innanzi tutto lo spettacolo della serialità più recente made in Sicily attraverso i momenti più significativi, a partire da L’arte della gioia di Valeria Golino con Tecla Insolia, Jasmine Trinca, Valeria Bruni Tedeschi (nella sua smagliante versione cinematografica); Vanina – Un vicequestore a Catania di Davide Marengo con Giusy Buscemi; i primi episodi, diretti da Piero Messina, de L’ora – Inchiostro contro piombo; e la Sicilia apocalittica di Anna di Niccolò Ammaniti. Accanto a questo panorama, un formidabile quintetto di prime mondiali (quattro opere prime e un’opera seconda) ci ricorda che la Sicilia è laboratorio di sempre rinnovate esperienze che spingono il suo cinema in avanti ma a 360 gradi: Quir di Nicola Bellucci, La bocca dell’anima di Giuseppe Carleo,Tre regole infallibili di Marco Gianfreda, Pietra madre di Daniele Greco e Mauro Maugeri e Il ladro di stelle cadenti di Francisco Saia. Anche autori consacrati siciliani hanno voluto aprirsi a nuovi esperimenti, come l’interpretazione free-jazz di Tony Sperandeo nel nuovo film di Aurelio Grimaldi, La rieducazione, un’altra prima mondiale.
Sempre al Palazzo dei Congressi uno spazio speciale è dedicato a OFFICINA SICILIA, in cui coesistono anime diverse fra loro. Innanzi tutto lo spettacolo della serialità più recente made in Sicily attraverso i momenti più significativi, a partire da L’arte della gioia di Valeria Golino con Tecla Insolia, Jasmine Trinca, Valeria Bruni Tedeschi (nella sua smagliante versione cinematografica); Vanina – Un vicequestore a Catania di Davide Marengo con Giusy Buscemi; i primi episodi, diretti da Piero Messina, de L’ora – Inchiostro contro piombo; e la Sicilia apocalittica di Anna di Niccolò Ammaniti. Accanto a questo panorama, un formidabile quintetto di prime mondiali (quattro opere prime e un’opera seconda) ci ricorda che la Sicilia è laboratorio di sempre rinnovate esperienze che spingono il suo cinema in avanti ma a 360 gradi: Quir di Nicola Bellucci, La bocca dell’anima di Giuseppe Carleo,Tre regole infallibili di Marco Gianfreda, Pietra madre di Daniele Greco e Mauro Maugeri e Il ladro di stelle cadenti di Francisco Saia. Anche autori consacrati siciliani hanno voluto aprirsi a nuovi esperimenti, come l’interpretazione free-jazz di Tony Sperandeo nel nuovo film di Aurelio Grimaldi, La rieducazione, un’altra prima mondiale.
 OFFICINA SICILIA è arricchita da una sottosezione di cinema siciliano ritrovato, intitolata IERI OGGI DOMANI, che vuole recuperare le opere più audaci del passato che annunciavano il cinema di oggi e quello che verrà, spaziando da un omaggio alla leggendaria Panaria Film, fondata nel 1947 dal principe Francesco Alliata di Villafranca di cui verranno presentate (proiezione in pellicola dei film restaurati) alcune delle produzioni più importanti: dagli audaci cortometraggi documentari alle due versioni differenti, per lingua e montaggio, di Vulcano e Volcano (1952) di William Dieterle. Accanto alla riproposta delle opere dei più sorprendenti registi della Costa Est come Maria Arena e il collettivo catanese canecapovolto, il cinema siciliano in bilico fra fiction e documento viene esplorato attraverso la produzione autoriale di Costanza Quatriglio e i lavori dei giovani documentaristi del CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo. Particolarmente prezioso è l’ultimo dei non-fiction in programma, Diario di Guttuso, un itinerario-mosaico che ricostruisce la vita di Guttuso attraverso luoghi, amici e quadri, un lavoro televisivo del 1982 che già annuncia la cifra personalissima del Premio Oscar Giuseppe Tornatore.
OFFICINA SICILIA è arricchita da una sottosezione di cinema siciliano ritrovato, intitolata IERI OGGI DOMANI, che vuole recuperare le opere più audaci del passato che annunciavano il cinema di oggi e quello che verrà, spaziando da un omaggio alla leggendaria Panaria Film, fondata nel 1947 dal principe Francesco Alliata di Villafranca di cui verranno presentate (proiezione in pellicola dei film restaurati) alcune delle produzioni più importanti: dagli audaci cortometraggi documentari alle due versioni differenti, per lingua e montaggio, di Vulcano e Volcano (1952) di William Dieterle. Accanto alla riproposta delle opere dei più sorprendenti registi della Costa Est come Maria Arena e il collettivo catanese canecapovolto, il cinema siciliano in bilico fra fiction e documento viene esplorato attraverso la produzione autoriale di Costanza Quatriglio e i lavori dei giovani documentaristi del CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo. Particolarmente prezioso è l’ultimo dei non-fiction in programma, Diario di Guttuso, un itinerario-mosaico che ricostruisce la vita di Guttuso attraverso luoghi, amici e quadri, un lavoro televisivo del 1982 che già annuncia la cifra personalissima del Premio Oscar Giuseppe Tornatore.
 Il festival vuole rendere omaggio a uno dei coraggiosi protagonisti del cinema fatto da chi vuole “restare a Sud”, il produttore Gaetano Di Vaio, scomparso di recente: Largo Baracche, documentario che lo stesso Di Vaio girò giusto dieci anni fa sui ragazzi della “Napoli di Gomorra” e Tre regole infallibili di Marco Gianfreda, l’ultimo film che Di Vaio aveva prodotto con la sua Bronx Film.
Il festival vuole rendere omaggio a uno dei coraggiosi protagonisti del cinema fatto da chi vuole “restare a Sud”, il produttore Gaetano Di Vaio, scomparso di recente: Largo Baracche, documentario che lo stesso Di Vaio girò giusto dieci anni fa sui ragazzi della “Napoli di Gomorra” e Tre regole infallibili di Marco Gianfreda, l’ultimo film che Di Vaio aveva prodotto con la sua Bronx Film.
A impreziosire l’offerta del Taormina Film Festival 70, la storia del festival ci porta due regali: lo strepitoso imperdibile monologo interpretato da Toni Servillo dall’opera seconda di Mario Martone, il mediometraggio Rasoi, e il restauro in 4K di Picnic at Hanging Rock, il capolavoro che impose ormai quasi 50 anni fa proprio a Taormina il regista australiano Peter Weir.
Per questa edizione l’otto volte direttore della Mostra di Venezia articola un programma ad ampio spettro culturale e geografico, non di solo cinema. Grazie all’impegno della direttrice artistica della Fondazione Taormina Arte Sicilia, Gianna Fratta, artista di fama internazionale, accanto alla rassegna cinematografica vive un’iniziativa parallela: PROIEZIONI – Suoni e parole prima del film, format di natura performativa tra musica, teatro ed eventi multimediali che offre, prima delle proiezioni al Teatro Antico, spettacoli legati al mondo del cinema. In particolare, la proiezione del documentario La Montagne Infidèle di Jean Epstein con il commento musicale dal vivo della pianista Omar Sosa; il concerto per il centenario della morte di Giacomo Puccini Tosca – Il ricatto sessuale, in cui arie, duetti e pezzi d’assieme del capolavoro pucciniano si alternano al racconto dell’opera fatto dalla stessa Gianna Fratta; Veniamo a quel paese, l’esecuzione delle colonne sonore che Carlo Crivelli ha composto per i film di Ficarra e Picone, che parteciperanno all’evento; Note di celluloide, omaggio che l’Ensemble “Suoni del Sud” tributa al meglio della musica per il cinema, eseguendo capolavori di Nino Rota, Ennio Morricone, Nicola Piovani, Piero Piccioni. Infine lo spettacolo teatrale L’amore segreto di Ofelia di Steven Berkoff con Chiara Francini e Andrea Argentieri e anche un omaggio a Maria Callas, Vissi d’arte. Vissi per Maria, che si svolgeranno tra la Villa Comunale di Taormina e il Teatro Antico.
Il 2024 segna un anno di svolta per il festival. La Fondazione Taormina Arte Sicilia, che da anni produce e organizza l’evento, intende attivare nuove strategie di promozione della manifestazione nel medio e lungo periodo. Il commissario straordinario Sergio Bonomo, in linea con le indicazioni strategiche dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo guidato dall’Onorevole Elvira Amata, finalizzate allo sviluppo della cinematografia in Sicilia e all’implementazione del cineturismo, pone le basi nel 2024 per un nuovo corso del Festival che, nei prossimi anni, intenderà attuare un’azione di apertura al territorio, con particolare attenzione alle zone costiere. Inoltre, come già nell’edizione 2024, in cui musica, teatro, multimedialità diventano parte integrante del programma festivaliero, il futuro della manifestazione mirerà a proporre un modello di festival moderno e altamente multidisciplinare, con azioni formative per i giovani, incontri, performance in cui le arti dialoghino sotto l’egida del cinema non come compartimenti stagni, ma in grado di creare nuove forme spettacolari, che possano prevedere anche attività coordinate con altri Paesi del Mediterraneo, in un’ottica di internazionalizzazione e apertura.
La Fondazione Taormina Arte Sicilia e il Taormina Film Festival 70 desiderano ringraziare MiC, Ministero Della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione Siciliana – Assessorato Turismo Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission, Comune di Taormina, AdSP dello Stretto, Sac, Aeroporto Di Catania, CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia; i main sponsor Intercity, Belmond Grand Hotel Timeo, Belmond Hotel Villa S.Andrea; gli sponsor tecnici Ibfor, Wella, Delta Marriott Hotels; Rai Sicilia per il patrocinio e i media partner Rai, Ciak, Cinematografo, Cinecittà News, Taxi Drivers, Variety.
Cinema
L’attrice Claudia Gerini si racconta al festival Onair

Abbiamo ripercorso 40 anni di carriera nel cinema e nella tv; intervistare Claudia Gerini, attrice dotata di straordinario talento e umiltà, nell’ambito del festival on air season, creato da Simona Gobbi, è stato come fare un viaggio nel tempo attraverso tutti i suoi successi cinematografici. 86 film e tanti sogni nel cassetto di Claudia..
-

 Cocker4 anni ago
Cocker4 anni agoIl cocker tanto famoso quanto intelligente
-

 In Evidenza4 anni ago
In Evidenza4 anni agoBiagio Conte: “Non vince il virus, Dio è più forte”
-

 In Evidenza4 anni ago
In Evidenza4 anni agoSicilia: zero decessi e zero pazienti in terapia intensiva
-

 Cinema6 anni ago
Cinema6 anni agoCinema e Massoneria un binomio misterioso e sorprendente
-

 Cocker8 anni ago
Cocker8 anni agoIl cocker è fra i cani più oziosi del mondo
-
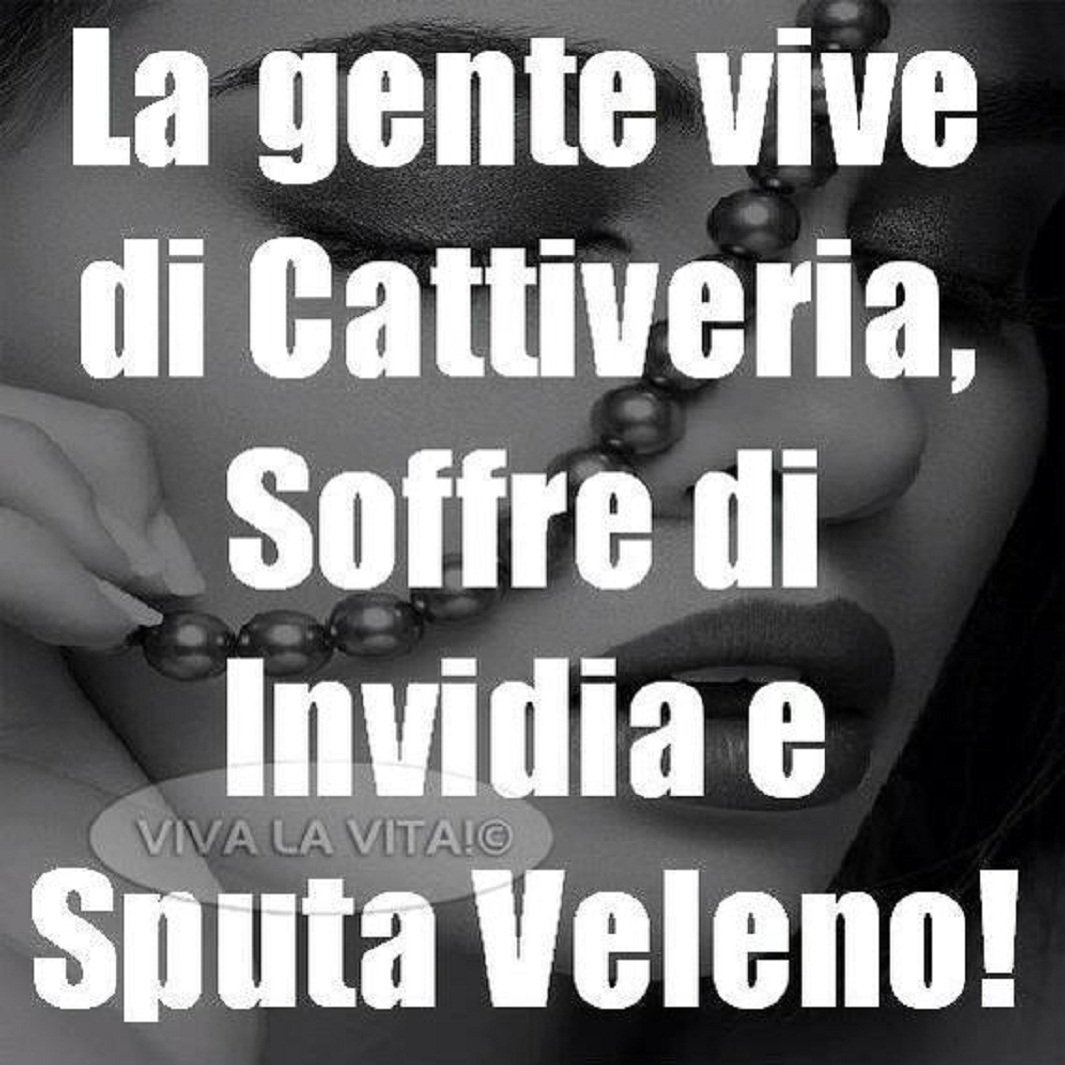
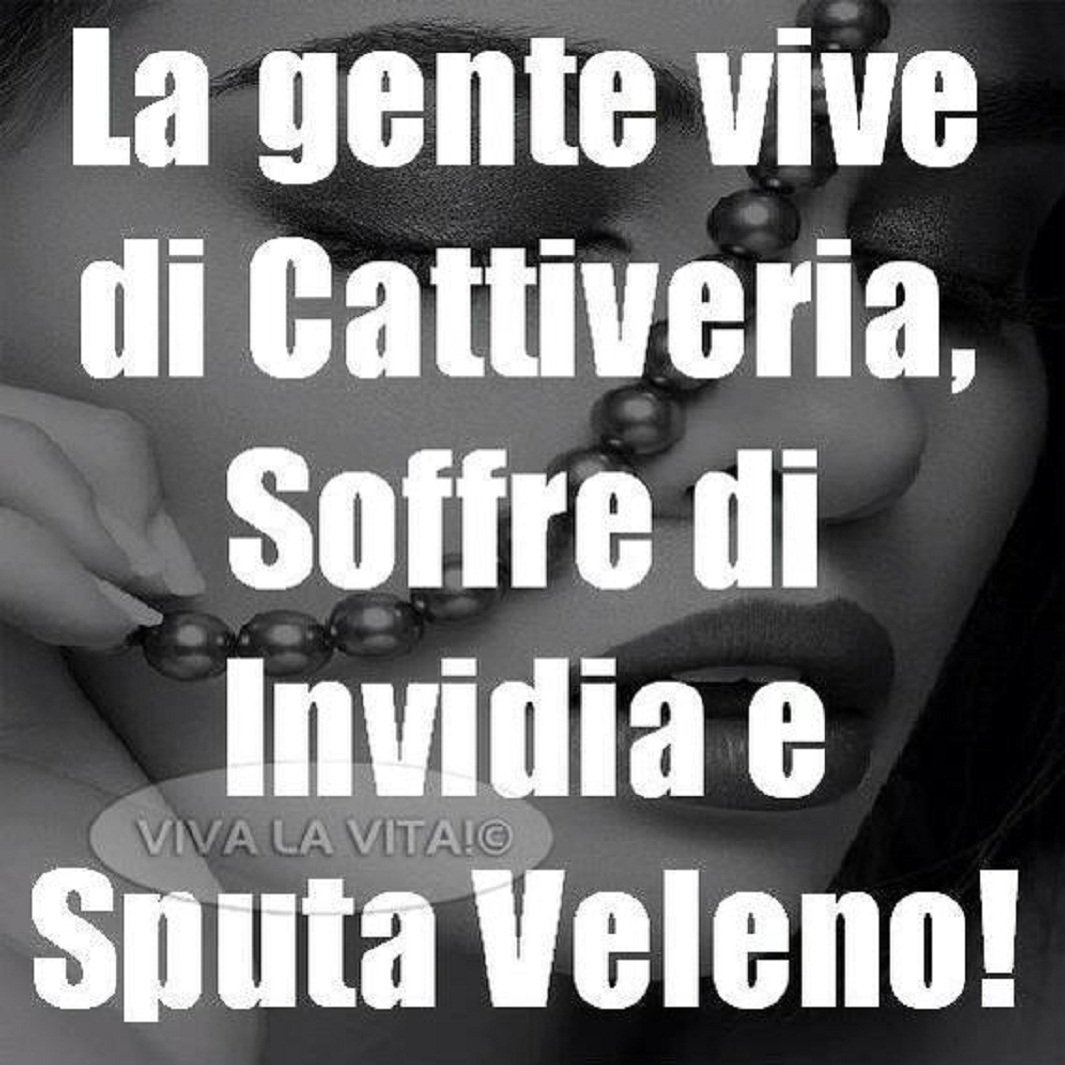 Editoriali16 anni ago
Editoriali16 anni agoL’invidia è la vendetta dell’incapace
-

 Cultura8 anni ago
Cultura8 anni agoLe stanze ferite: diario di viaggio nella Real Casa dei matti
-

 Cocker9 anni ago
Cocker9 anni agoIrish setter, cocker spaniel e cavalier king: “I cani rossi adottati prima degli altri”











